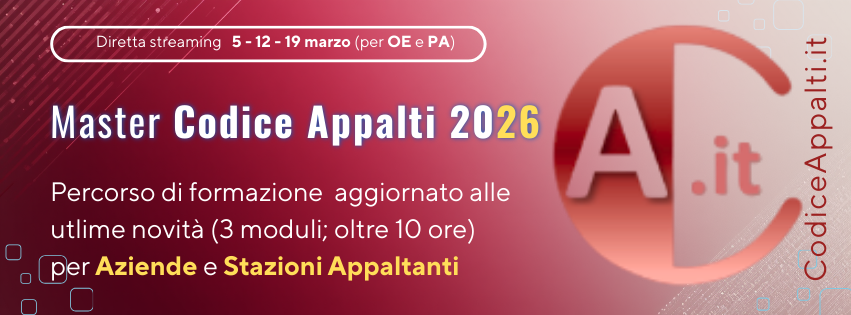Art. 118. Servizi di trasporto
1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO – NON SI APPLICA 63 DEL CODICE (63-118-122)
Il Collegio ha evidenziato, in via generale, che per il servizio di trasporto marittimo l’applicabilità dell’art. 63 del Codice dei contratti pubblici è espressamente inibita dagli articoli 118 e 122 del medesimo codice, atteso che quest’ultimo – per i contratti esclusi dalla sua applicazione, quali quelli di trasporto ferroviario menzionati nell’art. 118 – dispone che “Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto può essere ridotto fino a quindici giorni, nonché commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, può essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69; 73 e 74. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132”.
La Sezione ha peraltro rilevato che l’art. 47, comma 11bis, del decreto legge n. 50/2017 (il c.d. correttivo), convertito nella legge 96/2017, prevede espressamente che “Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia strettamente correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti” e che tale norma ha evidente carattere di specialità rispetto alle previsioni generali del Codice (comprese quelle sui settori speciali), in quanto disciplina lo specifico affidamento del servizio di trasporto marittimo mediante il riferimento espresso ad una clausola – l’art. 2, comma 1, lettera e), che affida in concessione a Ferrovie dello Stato s.p.a. “il collegamento ferroviario via mare fra la penisola e, rispettivamente, la Sicilia e la Sardegna” – del contratto di programma contenuto nel decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138 del 2000.
Il TAR evidenzia quindi che è tale norma la fonte del rapporto, che si inscrive, in questo modo, nel contratto di programma in essere tra lo Stato e Ferrovie dello Stato s.p.a.; la quale, a mente dell’art. 3, comma 2, della concessione, svolge le attività che di quest’ultima sono oggetto sia “direttamente”, che, previo parere del MIT, mediante affidamento a terzi, ferma la sua diretta responsabilità verso lo Stato.
ACQUISIZIONE CIG NEI SETTORI SPECIALI
Oggetto: Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, del codice dei contratti pubblici.
ATTIVITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI - RIENTRA NEI SETTORI SPECIALI SE IL SERVIZIO E' RESO SECONDO LE PRESCRIZIONI DELLE COMPENTENTI AUTORITA' (118)
In particolare, la stazione appaltante asserisce che non troverebbe applicazione al caso di specie l’art. 118 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), in primo luogo perché, sotto il profilo soggettivo, Trenitalia non sarebbe compresa nel novero dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria, contemplati dalla citata norma.
In secondo luogo viene rilevata, sul piano oggettivo, l’estraneità dell’attività oggetto di gara (manutenzione dei convogli, addetti al trasporto ad alta velocità) al predetto sistema di gestione della rete (affidato a Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a.), in quanto non vi sarebbe “gestione di rete”, intesa sia come infrastruttura fisica, sia come complesso di prescrizioni operative, stabilite da autorità pubbliche; il servizio di trasporto ferroviario ad alta velocità, inoltre, sarebbe liberalizzato e rappresenterebbe un mercato a sé stante, estraneo quindi all’ambito di applicabilità del secondo comma dell’art. 118 del d.lgs. 50/2016.
L’eccezione non può essere condivisa.
La controversia in esame riguarda l’affidamento di un servizio di manutenzione di treni destinati al trasporto ferroviario ad alta velocità, da considerare servizio pubblico di trasporto ferroviario, in quanto istituito per assicurare la mobilità dei cittadini sul territorio, in corrispondenza di interessi tutelati a livello nazionale e comunitario (articolo 16 della Costituzione e, da ultimo, direttiva 2014/25/UE). Appare ancora condivisibile, in particolare, il consolidato indirizzo, secondo cui la società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a., succeduta all’Ente Ferrovie dello Stato, ha acquisito la qualità di concessionario ex lege del servizio ferroviario, costituente servizio pubblico essenziale di interesse nazionale e riferibile allo Stato, con capitale sociale detenuto al 100% dal Ministero dell’Economia e qualificazione della società stessa come organismo di diritto pubblico (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2004 e giurisprudenza ivi citata). Quanto a Trenitalia – pure costituita in società per azioni, inserita nella holding di Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. e da quest’ultima interamente controllata – la natura giuridica della stessa quale organismo di diritto pubblico o di impresa pubblica non può che ricondursi, prioritariamente, alle finalità perseguite dal nuovo soggetto, richiedendosi che lo stesso – per concretizzare i requisiti, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d del d.lgs. n. 50 del 2016 – sia stato istituito per “soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”. La qualificazione giuridica in questione, d’altra parte, non sarebbe priva di conseguenze pratiche, essendo il predetto organismo – definito quale “amministrazione aggiudicatrice” – sempre tenuto a svolgere procedure contrattuali ad evidenza pubblica, in base alla parte prima o seconda del codice, ovvero seguendo le regole dei settori ordinari per i contratti estranei ai settori speciali (cfr. in tal senso Corte di Giustizia, sez. IV, causa C-393/06, ing. Aigner sentenza 10 aprile 2008, nonchè art. 133, comma 1, lettera e, punto 1, del d.lgs. n. 104 del 2010 – cod. proc. amm.).
Tenuto conto dell’obbligatoria separazione (più avanti meglio specificata) fra gestione dell’infrastruttura e servizio di trasporto tramite vettori, l’affidamento di quest’ultimo a Trenitalia, quale sostanziale emanazione della società Ferrovie dello Stato italiane s.p.a. (di seguito: F.S.), rende in effetti difficilmente ipotizzabile la sottrazione del medesimo alle finalità istitutive prioritarie – di carattere non industriale o commerciale – di mobilità da assicurare ai cittadini (anche su tratte che, ipoteticamente, il privato imprenditore o l’impresa pubblica potrebbero ritenere non percorribili, poiché non abbastanza remunerative). Sembra preferibile, pertanto, una valutazione che accomuni Trenitalia alla natura giuridica di F.S., quale ente geneticamente preposto ad un servizio pubblico essenziale di trasporto.
Ad avviso del Collegio, in ogni caso, la qualificazione giuridica di Trenitalia può ritenersi recessiva, tenuto conto dell’ampia nozione di “enti aggiudicatori”, quale emerge dal combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett e) e 114, comma 2, del d.lgs. 50/2016, con riferimento ai cosiddetti “settori speciali”, nell’ambito dei quali sono vincolati alle procedure concorsuali, disciplinate dal codice degli appalti, sia le amministrazioni aggiudicatrici che le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di un diritto di esclusiva: in ogni caso, pertanto, non potrebbe escludersi la giurisdizione di questo Tribunale, ove il contratto, da concludere nel caso di specie, fosse ritenuto attinente al settore, disciplinato nell’art. 118 del medesimo d.lgs. n. 50 (codice dei contratti pubblici).
Tale attinenza appare in effetti ravvisabile.
Per giurisprudenza ormai consolidata, infatti, sussiste l'obbligo di indire una procedura ad evidenza pubblica al ricorrere dei seguenti concorrenti presupposti: a) quando la procedura contrattuale debba essere avviata da “enti aggiudicatori”, come sopra specificati; b) quando oggetto dell'affidamento siano attività strumentali a quella svolta nei settori speciali (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 gennaio 2018, n. 590, che richiama la nota pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 1 agosto 2011).
Ciò posto, è opportuno richiamare l’art. 118 del citato codice, il quale dispone quanto segue:
“1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.
Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio”.
L’interpretazione della suddetta norma, alla luce delle modalità di formazione della holding di cui trattasi, esclude la rappresentata possibilità che i vettori, ossia i gestori dei convogli addetti al trasporto, siano esclusi dall’ambito della relativa applicazione.
La società F.S. S.p.a., nel separare i propri rami d’azienda, attribuendo distinte funzioni a Società controllate, esclusivamente competenti per singoli settori, ha esercitato la facoltà di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) del d.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, che consente di costituire imprese separate per la gestione della rete ferroviaria e per l'esercizio dell'attività di trasporto a mezzo ferrovia, peraltro in attuazione della direttiva CEE n. 440 del 1991.
Quanto sopra in coerenza con quanto stabilito dal successivo art. 4, commi 1 e 3, in virtù dei quali il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, soggetto autonomo ed indipendente rispetto alle imprese operanti nel settore dei trasporti, qualora sia titolare anche di un'impresa ferroviaria, deve svolgerne l'attività attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, almeno sotto il profilo contabile, rispetto a quelle destinate alle attività, espletate in qualità di vettore o d’impresa di servizi.
Il riparto delle competenze discende, inoltre, dalla definizione di infrastruttura ferroviaria delineata dall’art. 3, lett. c) del medesimo d.P.R. 277/1998 e ribadita dall’art. 2, lett. c) del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, secondo i quali, per i complessi immobiliari, rilevano e sono parti integranti dell'infrastruttura ferroviaria solo le porzioni direttamente inerenti alla circolazione dei treni ed alla gestione e manutenzione della rete ferroviaria.
Ciò premesso e venendo alla vicenda in esame, essa ha ad oggetto la manutenzione di treni ad alta velocità, che è strettamente connessa e strumentale alla gestione del servizio pubblico di trasporto che si svolge nel settore ferroviario.
Contrariamente a quanto affermato da Trenitalia, infatti, deve ritenersi che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti descritti dalla norma per affermare l’esistenza di una rete, tenuto conto degli importanti compiti che il d.lgs. 112/15 (cfr. in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b septies, nonché articoli 22, 24 e 26) attribuisce al gestore dell’infrastruttura (quale è Rete Ferroviaria Italiana RFI) in relazione alla individuazione (a titolo esemplificativo) delle tratte, degli orari, della frequenza e della capacità di trasporto.
E’ pur vero che, come afferma Trenitalia, essa si occupa dell’attività di trasporto passeggeri ed è soggetto diverso da quello preposto alla gestione/messa a disposizione della rete ferroviaria (anche in virtù del già ricordato divieto, ricavabile dall’art 2, co 1, lett. A) del d.lgs. n. 112/2015, che stabilisce il principio dell’autonomia e separazione tra gestori dell’infrastruttura e soggetti preposti all’esercizio dell’attività di trasporto a mezzo ferrovia); non è tuttavia possibile escludere che (anche) Trenitalia partecipi alle attività “relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario”.
L’opzione interpretativa della stazione appaltante muove, invero, da una lettura parziale, riferita al solo primo comma dell’art. 118, laddove per l’individuazione del settore speciale in questione occorre necessariamente fare riferimento al contenuto del secondo comma della norma, già sopra riportato.
Per l’individuazione di una rete di trasporto ferroviaria, che rientri nei settori speciali, occorre quindi non solo considerare l’aspetto inerente le “attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario…”, ma anche verificare se “il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche”: circostanza, quest’ultima, di certo sussistente nel caso di specie, se si tiene conto non solo degli importanti poteri di regolazione attribuiti dal citato d.lgs. 115/12 all’Autorità di settore (l’Autorità di Regolazione dei Trasporti), ma anche del carattere complementare dell’attività, svolta dal vettore in questione, rispetto a quella del gestore dell’infrastruttura (di cui costituisce emanazione), per la stessa delimitazione del servizio pubblico ferroviario, che lo Stato intende mettere a disposizione dei cittadini.
Ne consegue che l’attività di trasporto ad alta velocità, ancorché liberalizzata, non esula dal concetto di “rete”, come puntualizzato dal secondo comma del citato art. 118 del d.lgs. 50/2016, che ricomprende nel servizio pubblico di trasporto non solo l’infrastruttura fisica, ma – come già precisato nel primo comma – anche i vettori, purché inseriti in un progetto operativo, nell’ambito del quale l’autorità pubblica disciplina termini e modalità del servizio stesso, nella misura in cui ritenga di poterlo rendere accessibile alla cittadinanza..
Le suddette considerazioni trovano conferma in una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’unione Europea: sentenza 2019, C – 388/17 – Konkurrensverket contro SJ AB,
CONTRATTI PUBBLICI SETTORI SPECIALI – CONSORZI STABILI – SUBAFFIDAMENTO E SUBAPPALTO (45.2.c)
I consorzi stabili possono assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ai soli consorziati per i quali, in fase di presentazione dell’offerta, hanno dichiarato di partecipare, per cui ogni ulteriore affidamento ad altre imprese, soprattutto se consorziatesi successivamente all’espletamento della gara, devi ritenersi illegittimo. Inoltre, poiché a differenza delle riunioni temporanee di imprese il consorzio stabile opera come unica controparte del rapporto di appalto sia nella fase di gara che in quella di esecuzione del contratto, e in relazione alle singole consorziate opera sulla base di un rapporto organico, di modo che le attività compiute dalle consorziate siano imputabili organicamente al consorzio, è da ritenere inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, proprio in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo. Per la stessa motivazione e logica conseguenza deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori, servizi o forniture affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato, in quanto entrambi appartenenti alla medesima struttura giuridica, quindi riconducibili ad un unico centro decisionale. Del tutto diversa è, in via generale, l’eventualità che il consorzio affidi in subappalto i lavori, i servizi o le forniture a soggetti estranei alla compagine consortile e in possesso di adeguati requisiti, essendo ciò consentito alla luce del combinato disposto degli artt. 45, comma 2, lett. c), 114 e 118 del d.lgs. n. 50/2016.
OGGETTO: Procedura di gara indetta da A per il sub-affidamento dei servizi relativi alle linee di TPL extra-urbane Molfetta-Taranto e Gravina in Puglia-Taranto – Contratto di servizio tra Co.Tr.A.P. e A – Richiesta parere.