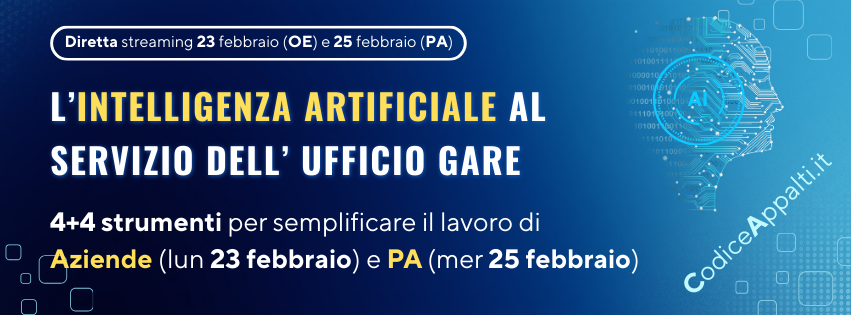INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO LETTERALE CORRELATO CON IL CRITERIO FUNZIONALE
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, che va invero verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell’art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626; Cass., 10/6/2020, n. 11092 ).
Si è altresì sottolineato che, nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il criterio letterale deve essere necessariamente riguardato alla stregua degli ulteriori criteri legali d’interpretazione, e in particolare, oltre al comportamento delle parti anche dopo la conclusione del contratto (art. 1362, 2° co., c.c.) (Cass., 30/8/2019, n. 21840), di quelli (quali primari criteri d’interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 20/10/2021, n. 28996; Cass., 10/6/2020, n. 11092; Cass., 6/12/2018, n. 31574; Cass., 13/11/2018, n. 29016; Cass., 30/10/2018, n. 27444; Cass., 12/6/2018, n. 15186; Cass., 19/3/2018, n. 6675) dell’interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c., che consente di accertare il significato dell’accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass., 13/11/2018, n. 29016) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c. [che quale criterio d’interpretazione del contratto – fondato sull’esigenza definita in dottrina di “solidarietà contrattuale” – si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235)], non consentendo di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale (cfr. Cass., 23/5/2011, n. 11295; e, da ultimo, Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882) (così Cass., Sez. III, ord. 08/03/2019, n. 34426).
Sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, l’elemento letterale va pertanto considerato non già isolatamente ma in correlazione con gli altri criteri ermeneutici, e primariamente quello funzionale, in coerenza cioè con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare (“causa concreta”) mediante la stipulazione (Cass., 12/11/2019, n. 11092; Cass., 6/7/2018, n. 17718; Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con la quale convenzionalmente determinano la disciplina accettata come vincolante (art. 1372 c.c.) del loro rapporto contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882, cit.; Cass., 6/7/2018, n. 17718, cit.).
A tale stregua, “l’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. non consente, quale criterio d’interpretazione del contratto, di dare ingresso ad interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell’accordo negoziale” (nuovamente Cass., Sez. III, ord. 08/03/2019, n. 34426, cit., che si segnala per la considerazione della “causa concreta” quale elemento cardine ai fini interpretativi del contratto).
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui